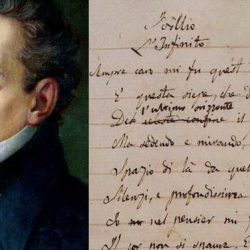Per noi il calcio è un fenomeno di costume e gli aspetti tecnici competono ad altri, anche se pensiamo che qualche osservazione non peregrina sarebbe alla nostra portata: ma ce ne asteniamo. Un’altra doverosa premessa è la nostra imparzialità: in fuga dal galleggiamento delle squadre genovesi che ci riguarderebbero (l’una o l’altra, s’intende), non siamo interisti.
Sappiamo pure che gli amarcord sono stucchevoli e querimoniosi, però ci toccano, è fatale per la nostra generazione e cediamo alla voluttà.
Bimbi, osservavamo i nostri papà attaccarsi alle radioline, mentre passava “Tutto il calcio minuto per minuto”, sorbendoci, piacevolmente, le tante voci tra le quali spiccavano quelle di Nicolò Carosio, Enrico Ameri e il “blues” Sandro Ciotti.
Oggi non si può esprimere l’emozione che sapevano trasmettere le radiocronache; per quanto le si possa risentire, nessuno che non le abbia vissute in diretta può immaginare il trasferimento emozionale che transitava dall’udito alla visualizzazione degli amati eroi in calzoncini.
Le star del pallone degli anni sessanta, quando la televisione, in qualche modo, iniziava ad occupare massicciamente i tinelli e si potevano guardare i divi come ospiti di casa, erano molti: ragazzi che forse tendevano a dimostrare qualche anno in più, spesso già padri di famiglia molto giovani, alquanto inquadrati, capello corto. Il “ribelle” George Best non era un esempio molto seguito, se non da Gigi Meroni, sfortunato football player del Torino, indimenticato beat del calcio.
A punteggiarne le gesta, anche in video, arrivarono altrettanti miti delle telecronaca, da Nando Martellini e Bruno Pizzul. Di quest’ultimo restano leggendarie le introduzioni o creazioni lessicali: da “sparacchia” a “si accinge alla bisogna”.
Allora Milano riusciva ad arginare il colosso juventino, anzi spadroneggiava, e costituiva l’ossatura della nostra nazionale, che in verità arrancò per quel decennio, con le barbine figure di Cile 1962 e Inghilterra 1966. Riguardo a questo torneo, oggi è in atto una inevitabile revisione; secondo molti Pak Doo Ik, il coreano che ci mandò a casa con il suo goal, non era un dentista, come si favoleggiò allora (a indicare la vergogna di un gruppo di professionisti ben pagati, come gli italiani, sconfitti da alcuni diavoletti sfigati del terzo mondo comunista): ma la faccenda si rivelò più complessa e chi sa di storia calcistica certamente la conosce.
Sull’episodio dell’infausta rete si discusse a lungo, addossando la “colpa” a Giacinto Facchetti, la star della nostra squadra, che, alto il triplo, avrebbe dovuto fermare l’avversario con un mignolo: ma alla fine arrivò il perdono.
Giacinto, nato a Treviglio, nella bergamasca, classe 1942, era un uomo splendido, di una prestanza stordente, il viso chiaro, dallo sguardo lucente che spesso hanno i nativi di quel territorio. E a parte il talento specifico, in comune con il suo popolo aveva tenacia, disciplina, senso del dovere.
Terzino mobile, pronto alla falcata con le sue gambe di infinita lunghezza, magari supportando l’attacco e segnando a sua volta, portò vari allori e fu protagonista dell’orgasmico Italia Germania 4-3, nel 1970. Egli proseguì la carriera nell’amata Inter e fu inviato da commentatore ai mondiali di Francia 1998, con una sorprendente padronanza del francese.
Perché Giacinto proveniva, sì, da una famiglia non abbiente, come spesso accadeva allora, ma portava in petto il desiderio di riscatto attraverso l’impegno. La sua scomparsa nel 2006 addolorò mezzo mondo, poiché la sua personalità aveva scavalcato i confini; e i sussurri denigratori che lo avevano addolorato negli ultimi anni, forse fiaccandone il morale, appaiono destituiti di fondamento.
Suo partner indefettibile, in campionato e nel team azzurro, era il friulano Tarcisio Burgnich (1939/2021). Evitiamo la consueta etichetta di “roccia” che lo ha sempre perseguitato, preferendo un “ghiaccio bollente”. Freddo e poco propenso ai sorrisi, composto e quasi militare, in gara tirava fuori la sua energia che, come una tenaglia, avvolgeva chi fosse capitato sotto la sua marcatura, non disdegnando, a sua volta, incursioni in porta, come in effetti accadde durante i supplementari allo stadio Atzeca, con i teutonici: suo il pareggio del 2-2.
Una rivisitazione, a suo parere, era dovuta nell’analisi della sfortunata finale col Brasile, persa 4-1: gli italiani erano stanchi, e per aver giocato un giorno dopo i brasiliani e per l’impegno del match con i tedeschi. Tuttavia non vogliamo crogiolarci nei rimpianti: dopotutto, c’era ancora Pelé, sarebbe stata dura comunque.
Dal gioco a uomo a quello a zona, a tutto il resto che abbiamo visto sfilare sotto i nostri occhi nei decenni, ci rimane sempre difficile immaginare personaggi più carismatici e fascinosi di questi. Affermava Burgnich: “I difensori forti sono sempre meno. È venuta meno la passione. Per noi qualsiasi spiazzo, anche sterrato, con la ghiaia per terra, era perfetto per giocare. Pensavamo sempre al pallone e anche in strada imparavi tanto, ti insegnava a combattere. Ora il calcio è visto come un lavoro, i giocatori sono meno continui. E io seguo meno, non mi piace tanto stare a guardare”. (Assocalciatori.it.)
Che tali parole rappresentino un modo per accontentare l’ennesimo intervistatore, o scaturiscano da nostalgia dovuta al peso degli anni, i due “fiori del nostro giardino”, colonne di uno stile assolutamente scomparso, meritano un tributo e un imperituro ricordo.
Carmen Gueye