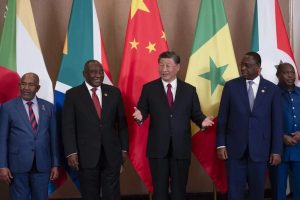L’avevano annunciato e così è stato: Cina e Corea del Sud hanno dichiarato guerra alle criptovalute, le monete digitali che circolano dal 2009 e consentono di effettuare pagamenti online. La stretta ha provocato un notevole crollo delle due criptomonete principali, Bitcoin e Ethereum, rispettivamente del -13% e del -17%. L’uso delle criptomonete si lega all’attività di trading, ovvero la compravendita online di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, titoli di stato.
La Cina fa retromarcia rispetto al 2014, quando la Banca Popolare cinese aveva avviato una serie di simulazioni per essere la prima banca al mondo ad utilizzare il proprio prototipo di criptomoneta. Ultimamente, il governo cinese aveva già limitato le attività nelle miniere di criptovalute e vietato il trading dalle piattaforme di scambio, spinta dalla necessità di tenere d’occhio uno strumento estremamente incerto, che “non si sa quanto vale, quando comprare o quando vendere”.
In particolare, in Corea del Sud si concentra il 20% degli scambi mondiali di criptomonete, ma non appena il ministro della Giustizia di Seul, Park Sang Ki, ha annunciato il blocco delle piattaforme di scambio, il mercato ha subito un calo immediato, segno della potente influenza della regolamentazione sui bitcoin. Quella che per alcuni poteva essere una valida alternativa all’uso del dollaro come mezzo di scambio internazionale, si sta rivelando una bolla speculativa, tesa nella continua speranza che salga di valore.

La decisione dell’Estremo Oriente è stata guidata dalla volontà di porre un freno all’evasione fiscale e alla dipendenza da gioco d’azzardo. Nonostante i limiti nazionali, però, gli esperti del settore fanno notare che gli appassionati di trading online si sposteranno su altre piattaforme o in altre nazioni per continuare i propri investimenti. Proprio i sudcoreani hanno firmato una petizione per chiedere alla Camera Blu Presidenziale di fermare il divieto contro i bitcoin, il che ne dimostra la diffusione tra gli abitanti.
Ciò su cui si dovrebbe riflettere è l’instabilità del bitcoin, legato all’andamento della domanda: a metà dicembre, il bitcoin superava la quota dei 19mila dollari, mentre ora si trova sotto i 13mila. Ciò testimonia che, non appena si diffondono notizie di una possibile regolamentazione, la criptovaluta comincia a perdere valore. L’assenza di regolamentazione costituisce un punto di forza dei bitcoin, perché li slega da procedure burocratiche che ne rallenterebbero il corso e, se digitale equivale a veloce, il gioco è fatto.
L’altra faccia della medaglia, però, è rappresentata dalla mancanza di tutele, poiché il sistema consente di agire anche anonimamente. A differenza dei tradizionali sistemi bancari, le criptovalute non rispettano un principio gerarchico, ma sono costituite da reti di soggetti paritari indipendenti da qualsiasi Autorità centrale.
Se si pensa che i bitcoin rappresenterebbero un’ottima soluzione per pagamenti di armi, droga, riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, si conclude presto che l’esempio dell’Estremo Oriente potrebbe essere seguito anche da altri Paesi. Invece no: gli Stati Uniti, seppur preoccupati dalla vicenda, potrebbero autorizzare l’acquisto dei biglietti di NBA in criptovaluta, nonostante il mese scorso avessero annunciato una nuova tassa sugli scambi che, paradossalmente, renderebbe i bitcoin un sistema più facilmente accettato.
C’è anche chi sostiene che le criptomonete siano un’alternativa alle banche centrali, ma finora queste ultime hanno rassicurato che i bitcoin non rappresentano una minaccia per loro. In economia bisogna saper rischiare, ma le criptovalute non convincono molto. Il crollo dei bitcoin dimostra che digitale non è sinonimo di immune e il mercato non risparmia nessuno.
di Antonella Gioia
Maggio 13, 2024